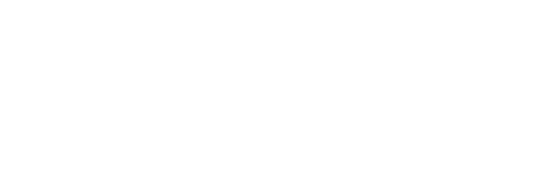Così vicina a Genova, Nervi ne seguì tutte le tappe storiche: città romana e poi cristiana, fu invasa dai Goti e governata successivamente dai Bizantini, dai Longobardi e dai Franchi, che affermarono infine il sistema feudale.
All’interno del sistema feudale, i preti di campagna, i piccoli proprietari e gli artigiani costituirono gli uomini liberi. Grazie a loro il borgo di Nervi si formò come circoscrizione religiosa e civile crescendo attorno alla propria chiesa, che ereditò il ruolo di guida amministrativa, economica e politica delle comunità rurale col nome di chiesa plebana, ovvero “del popolo”. Nel Medioevo la chiesa plebana divenne un’importante struttura autonoma, talmente elastica che riuscì a garantire unità e identità alle popolazioni locali sottoposte ai vari domini.
In Liguria, crocevia del Mediterraneo, il cristianesimo si diffuse assai presto: i più antichi vescovi di Genova risalgono ai primi secoli dopo Cristo.
A Nervi i primi cristiani si radunavano nella chiesa agreste, che acquistò immediatamente il ruolo guida di chiesa plebana, ovvero chiesa di campagna dotata di battistero e posta a capo delle chiese minori vicine. Ciascuna chiesa plebana era infatti al centro di una “pieve”, ovvero di quell’area rurale che i Romani chiamavano “pagus” . Nel levante genovese sei “pagi” romani diventarono pievi in età cristiana: Albaro, Nervi, Sori, Recco, Uscio e Camogli. Nervi acquistò quindi grande importanza come sede della plebana di San Siro, cui furono riconosciute funzioni civili e catastali.
Dall’Archivio della Curia sappiamo che nell’anno 1040 San Siro era una delle ventidue chiese plebane della Diocesi di Genova. Venne costruita su un fondo arcivescovile ai piedi della collina e gli studiosi concordano nel supporne l’esistenza già prima del Mille, in epoca paleocristiana. Oggi è ben visibile la facciata romanica in pietra, recuperata sotto la chiesa attuale. Quella di Nervi è una testimonianza esemplare di pieve medievale.
Gli archivi ecclesiastici e civili ci permettono di accedere alle più antiche notizie su i beni, le decime, la vita sociale ed i lavori agricoli della nostra antica pieve. Sappiamo tutti che Genova divenne una repubblica marinara governata da consoli, sull’esempio dell’antica Roma. Ebbene, il modello della pieve si adeguò facilmente alla nascente istituzione comunale, che tendeva a svincolarsi dal potere imperiale appoggiandosi al vescovo. Anche Nervi cominciò ad eleggere i propri consoli, scelti in numero di tre o quattro tra uomini di prestigio e fiducia; erano convocati in riunione al suono del corno o della campana all’interno della chiesa, avevano autorità su ogni questione e prendevano il comando militare in caso di necessità. I primi consoli di Nervi risalgono al 1148.
La chiesa plebana venne dedicata a san Siro, che fu probabilmente di madre nerviese.
All’interno della chiesa di Nervi il Santo compare rappresentato negli affreschi decorativi settecenteschi ed in una pala cinquecentesca.
Tra i primi vescovi di Genova, san Siro spicca come figura di grande rilievo: gli furono attribuiti vari miracoli e gli fu dedicata l’antica basilica del centro storico genovese, duomo cittadino fino all’anno 985, quando passò il titolo a San Lorenzo. Non a caso la cattedra episcopale di Genova si chiama ancora Cattedra di San Siro.
La storia del Santo ci fu trasmessa dal racconto del frate domenicano Jacopo da Varazze, arcivescovo di Genova, che nel XIII secolo scrisse la “Legenda Aurea”, raccontando le vite dei santi. Siro nacque dunque nel IV secolo a Struppa, in val Bisagno, dove ancora troviamo la chiesa abbaziale benedettina a lui intitolata. Si tramanda che fosse figlio di un certo Emiliano Dolcino, sposato con una buona cristiana nata a Nervi. I genitori l’avrebbero affidato all’educazione del vescovo Felice. Ordinato diacono, fu mandato a Villa Matutia (oggi Sanremo), dove dimostrò subito una straordinaria capacità di attrarre le persone alla fede cristiana. Dopo alcuni anni, venne richiamato a Genova dal vescovo Felice e ne divenne il successore per volontà del clero e del popolo.
Secondo la tradizione, Genova era allora appestata da un grosso basilisco, che viveva in fondo ad un pozzo. Il vescovo Siro stette tre giorni in preghiera e penitenza, poi andò al pozzo e ordinò al mostro di scomparire in mare. Per questo appare spesso raffigurato mentre scaccia il basilisco, velenosissimo re dei serpenti e simbolo dell’eresia, che minacciava il Primo Cristianesimo e che facilmente si diffondeva nei centri marittimi.
Entriamo ora nella Plebana di Nervi e fermiamoci davanti alla pala cinquecentesca di Pietro Francesco Sacchi: ci mostra un san Siro autorevole, seduto in cattedra tra i santi apostoli Andrea e Bartolomeo, difensori della verità evangelica, mentre il basilisco è raffigurato a terra come un cattivo mostriciattolo. Vediamo però anche dipinto un piccolo merlo: si riferisce infatti che da bambino Siro avesse per fedele amico un merlo e che, trovatolo morto, lo avesse resuscitato con una preghiera, posandogli un poco di saliva sugli occhi. Da un semplice gesto d’affetto e di devozione infantile sarebbe scaturito il primo segno di santità, che l’animo sensibile del pittore non volle trascurare.
Di Marcella Rossi Patrone.