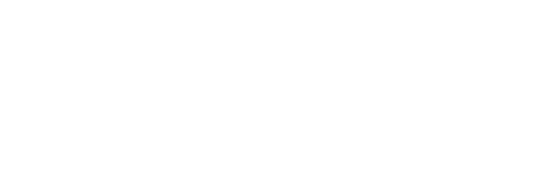All’estremità occidentale della baia di Nervi, dove sale l’attuale via Provana di Leyni, in epoca medievale si trovava la chiesetta del Santo Sepolcro, successivamente intitolata a San Paolo. I due nomi con cui ci è stata tramandata rimandano chiaramente alla storia del pellegrinaggio cristiano verso Gerusalemme e verso Roma, verso il Santo Sepolcro e verso la tomba dell’apostolo Paolo. Quest’ultimo, che fu uomo d’azione, viaggatore e comunicatore, venne anche considerato il primo pellegrino della cristianità. Pertanto non ci stupirà che accanto a questa piccola chiesa esistesse un hospitale, ovvero una casa ospizio gestita da religiosi. Il primo concilio ecumenico del mondo cristiano, tenutosi a Nicea nell’anno 325 d.C., aveva infatti incaricato i vescovi di alloggiare i bisognosi e di creare adeguate sedi di accoglienza. Le finalità e gli ordinamenti comuni facilmente collegarono gli edifici destinati all’ospitalità, creando una vera e propria rete.
Solitamente le pievi rurali nate sulle stazioni di sosta romane, quindi in particolari posizioni di transito lontano dalle città, possedevano degli ospizi e concorsero grandemente alla crescita di tali strutture. Nervi era una di queste pievi rurali e l’ospizio fu costruito sulla via pubblica che conduceva alla baia, una condizione indispensabile alla sua stessa funzione.
La Pieve di Nervi fu un importante riferimento religioso e civile. Il ruolo che assunse verso l’assistenza ai pellegrini fu determinato dal progressivo incremento della vita comunitaria e dalla necessità di fronteggiare il passaggio dei viandanti da e per Genova. L’hospitale offriva un pasto frugale ed un tetto, aggiungiamo che era in una posizione incantevole: percorrendo la via romana da ponente e da levante, si saliva al Capo, così era chiamato il piccolo promontorio, ed improvvisamente lo sguardo si apriva sulla baia di Nervi, con un panorama sbalorditivo che sicuramente invitava alla sosta.
Le strade esistevano e continuavano ad esistere in relazione all’uso che se ne faceva. Naturalmente all’interno di un’area di cammino potevano essere effettuati percorsi
diversi, ma nel nostro caso esisteva un’unica via costiera, che costituiva un passaggio obbligato. Quello del Capo di Nervi potrebbe a buon diritto essere considerato tra quegli ospizi detti “di passo”, che nel Medioevo formarono fondamentali itinerari dotati di stazioni, più o meno ad una giornata di cammino le une dalle altre. Questi antichi itinerari mossero persone e commerci, nonostante i pericoli di aggressione e le strade strette, ripide, tortuose, prive di manutenzione. A dispetto delle difficoltà pare che per Nervi si spostassero un gran numero di persone, lentamente a piedi o più rapidamente per mare, anche perché l’antica Pieve ebbe la caratteristica di non essere isolata, ma di aver intorno a sé una serie di centri abitati e vitali. Fu così che i nerviesi videro muoversi attorno a loro dignitari, guerrieri, invasori e pellegrini.
La possibilità di sostare gratuitamente giocava un ruolo decisivo nel successo degli ospizi nati in seno alla Chiesa. Non è possibile parlare di ospitalità medievale senza tener conto dei profondi cambiamenti che il cristianesimo e l’organizzazione ecclesiastica operarono sulla società occidentale. Durante il Medioevo la fede e le strutture religiose plasmarono la vita delle persone sotto ogni aspetto.
I pellegrini appartenevano a tutti le categorie sociali, avevano differenti gradi di istruzione, ma erano innanzi tutto persone di fede. Uomini, donne, bambini, malati, tutti erano disposti ad affrontare disagi ed a viaggiare, spesso come gruppo solidale, sempre animati da una forte spiritualità.
Gli si diede protezione, ma bisognava anche riconoscerli. Così, prima di partire, ogni pellegrino riceveva la benedizione sacerdotale e con un rito particolare gli venivano consegnate un bordone ed una bisaccia. Riconoscere un pellegrino diventò facile, perché aveva come insegne essenziali bordone e bisaccia, ai quali si aggiunsero poi la tunica col cappuccio o il cappello a larga tesa.
Il bordone era il grosso e lungo bastone dal manico ricurvo, usato come sostegno nel camminare e come arma impropria per difendersi; a volte era fornito di un gancio per appendervi una zucca cava contenente l’acqua. La bisaccia era una piccola sacca di pelle, che doveva contenere solo i documenti e dei piccoli utensili.
Il vero pellegrino non poteva portare altro con sé, per il resto confidava nella Provvidenza e naturalmente nell’hospitale.
Così andavano le cose nel Medioevo.
Di Marcella Rossi Patrone